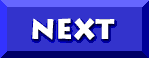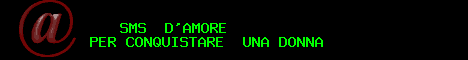GRAMMATICA MINIMA LINGUA NAPOLETANA
GRAMMATICA PAG. 1 - 2 - 3 - 4
- Grammatica Minima di Napoletano -
Qui l�apprendista trover� alcune indicazioni in merito ai casi dubbi che pi�
spesso possono capitare nella pronuncia o nella scrittura della lingua napoletana.
Questo riassunto di regole � diviso nei seguenti paragrafi:
I Note d�Aiuto per la Pronuncia
II L�Elisione, il Troncamento, lo Spirito
III Il Sostantivo
IV il Verbo
V L�Aggettivo
VI Gli Articoli
VII L�Avverbio
VIII Le Preposizioni
IX I Numerali
X I Pronomi
XI Le Congiunzioni
I
Note d�Aiuto per la Pronuncia
1 Vocali non toniche
Spesso, le vocali non toniche (su cui cio� non cade l�accento), e quelle poste
in fine di parola, sono pronunciate con un suono centrale indistinto che i
linguisti chiamano �schwa� e che nell�Alfabeto Fonetico Internazionale �
trascritto col simbolo / ə /. Esso � il suono che ritroviamo, ad esempio,
nella pronuncia della � e � semimuta del francese < petit >.
2 Pronuncia forte e debole
In Napoletano, alcune parole hanno due distinte pronunce: una forte e una
debole; ad esse corrisponde una diversa enfasi del termine.
2.1 In generale, in Napoletano, la prima pronuncia si differenzia dalla
seconda per l�emissione ben marcata della vocale finale, in luogo
dell�abituale suono indistinto di cui si � parlato sopra. In questi casi si
pronuncia una � u � finale per la forma maschile, una � a � finale per quella
femminile, e una � i � finale per le forme plurali maschili o femminili.
2.2 La pronuncia forte si utilizza (ed � obbligatoria), soprattutto in casi
specifici. Con alcuni aggettivi, per esempio, se posti prima del sostantivo a
cui si riferiscono; mentre � errato adoperarla se l�aggettivo segue il nome.
Ad esempio:
nu bellu guaglione ( un bel ragazzo )
In questo caso, poich� l'aggettivo precede il nome, ed � tra quelli per cui
esiste una pronuncia forte, essa � obbligatoria, per cui la � u � finale andr�
pronunciata ben distintamente. Se per� avessimo detto �nu guaglione
bello�, le vocali poste in finale di parola avrebbero avuto il suono indistinto
della pronuncia debole.
3 Accento sull�ultima sillaba
In genere, le parole che terminano per consonante, di solito lasciti stranieri,
portano l�accento sull�ultima sillaba.
Ad esempio:
Merced�s ( Mercedes ).
3.1 Unica eccezione (dal sapore neoborbonico) sembra essere:
C�vur ( Cavour ).
4 Vocali e Consonanti
4.1 [ a ]
La vocale aperta arrotondata � a �, � pronunciata / ɑ / piuttosto che / a
/ come in italiano.
4.2 [ a ] [ e ] [ o ]
Anche se sono sempre segnate si leggono spesso mute anche a fine parola.
Ad esempio:
Aqua ( acqua ) si legge quasi: acq�.
4.3 [ � ]
La � � � diacritica / i /, presente nei gruppi � -cia � / -ʧa / e � -gia � / -ʤa
/, viene talvolta pronunciata.
Ad esempio:
Na cruciera ( una crociera ) si legge: �na cruc�era.
4.4 [ b ]
Si pronuncia spesso come � v �.
Ad esempio:
baso ( bacio ), si legge: vaso.
4.5 [ d ]
� frequente il rotacismo della / d /, cio� il suo passaggio a / r / ( / ɾ / )
soprattutto se essa si trova tra due vocali, o ad inizio di parola seguita da
vocale.
Ad esempio:
dim�ne ( domani ) si legge quasi: rim�ne.
4.6 [ g ]
In principio di parola, soprattutto nei gruppi � gua /gwa � e � gue /gwe �,
spesso la occlusiva velare sonora / g / seguita da vocale diventa
approssimante / ɤ /.
Ad esempio:
guerra ( guerra ) si legge quasi: gv�erra.
4.6.1 Se � seguita dalla vocale � u � o dalla consonante � r �, pu� avere
suono molto debole e quasi non si pronunzia.
Ad esempio:
gratt� ( grattare ) si legge quasi: �ratt�.
4.7 [ j ]
Quando la � i � � semivocalica a inizio parola (una � i � seguita da un�altra
vocale, di solito trascritta come � j �), in alcuni casi viene pronunciata con
suono forte e suona quasi come: � -ggh �.
Ad esempio:
jettatura ( jettatura ), si legge quasi: ghiettat�ra.
4.7.1 All�interno della parola ha suono debole e suona come � i �.
Ad esempio:
ajere ( ieri ), si legge quasi: �iere.
4.8 [ s ]
La fricativa alveolare non sonora / s /, in posizione iniziale, seguita da
consonante, viene spesso pronunciata come fricativa postalveolare non
sonora / ʃ /; assume, quindi, il caratteristico suono strisciato simile a
quello di < sh > nella lingua inglese.
4.8.1 Ci�, per�, non accade, quando essa � seguita da un�occlusiva
dentale / t / o / d /.
Ad esempio:
scus� ( scusare )
4.9 [ v ]
Si pronuncia spesso come � b �.
Ad esempio:
ved� (vedere), si legge: bed�.
5 Gli Accenti
Si distinguono in tre tipi:
5.1 [ ` ]
Aperti, o gravi. suono largo
� � / � / � �
5.2 [ � ]
Chiusi o acuti: suono stretto.
� � / � / � / � �
5.3 [ ^ ]
Circonflessi: indicano contrazione di pi� vocali.
� � / � / � / � �
II
L�Elisione, il Troncamento, lo Spirito
1 Tipi di Apostrofo
Nel tentativo di semplificare la scrittura di questa lingua senza trascurare le
ragioni dei termini, abbiamo scelto di segnare l�elisione, il troncamento e,
nel solo caso degli articoli determinativi, lo �spirito�, nei seguenti modi:
1.1 [ � ]
Apostrofo, per indicare l�elisione dell�ultima lettera di una parola che sia una
vocale, non accentata, seguita da un�altra parola che inizi per vocale.
1.2 [ ` ] [ � ]
Accento grave o acuto, per indicare la caduta di un�intera sillaba.
1.3 [ � ]
Lo spirito aspro, scelto sia per distinguere gli articoli dalle congiunzioni o
dalle preposizioni, sia in omaggio ad un legame del Napoletano al Greco,
precedente a quello col Latino.
III
Il Sostantivo
1 Pronuncia identica sia nel Singolare che nel Plurale
A seguito dell'indebolimento della vocale finale, molti nomi hanno una
pronuncia identica sia nel singolare sia nel plurale. Le due forme si
distinguono grazie all'utilizzo del differente articolo, alla presenza o meno
del rafforzamento sintattico, alla concordanza del verbo.
1.1 Altri sostantivi hanno invece una forma distinta per il plurale,
talvolta basata sulla mutazione della vocale tonica.
Ad esempio:
�o cartone ( il cartone ), diventa:�e cartune.
2 Mutazione della Vocale Tonica
La mutazione della vocale tonica serve anche ad ottenere il maschile di
diversi aggettivi o sostantivi.
Ad esempio:
rossa ( rossa ), diventa: russo ( rosso ).
3 Genere Neutro
Il genere neutro � presente, ad esempio, negli aggettivi dimostrativi,
Ad esempio:
�o niro, (il nero), si riferisce a una persona di
colore, di sesso maschile.
�o nniro (il nero), col raddoppiamento della � n �, �
adoperato al neutro, e si riferisce al colore nero.
IV
Il Verbo
1 Av� e Ten�
In Napoletano, il servile �dovere�, � espresso con la circonlocuzione �av�
da/av� �a � (avere da) e, quindi, col verbo Av� (Avere).
1.1 Bisogna tenere presente, per�, che se il verbo servito inizia per
vocale, la preposizione del costrutto �da / �a �, fa corpo con la prima sillaba
del verbo. Essa presenta, quindi, l�accento circonflesso.
Ad esempio:
aggio �rravugli� (devo/ho d�avvolgere), da: aggio �a
arravugli�.
avite �llucc� (dovete/avete da gridare), da: avite �a
allucc�.
1.2 Per la sola seconda persona singolare, qualora il verbo servito dalla
circonlocuzione inizi per consonante, e per offrire una segnatura che sia pi�
fedele alla parlata reale, nei testi, abbiamo preferito contrarre la
preposizione all�ausiliare, e non al verbo servito.
Ad esempio:
he �a cammen� (devi/hai da camminare) da: h� cammen�.
1.3 Il verbo Av� non ha mai il significato di possedere: in tal caso si
usa il verbo: Ten�.
Ad esempio:
tenco a nu ciuccio (ho un asino).
2 Declinazione dei Verbi
2.1 Infinito
-� -� -� -ere
Parl� Car� Part� v�ncere
2.2 Presente
-� -� -� -ere
Io parlo caro parto venco
Tu parle care parte vince
Isso �ssa parla care parte vence
Nuje parlammo carimmo partimmo venimmo
Vuje parlate carite partite venite
Loro p�rlano careno p�rteno v�nceno
2.3 Passato Prossimo
-� -� -� -ere
Io aggio parlato so� caruto so� partuto aggio vinciuto
Tu haje/h� parlato si� caruto si� partuto haje/h� vinciuto
Isso �ssa ha parlato � caruto/a � partuto/a ha vinciuto
Nuje avimmo/ammo parlato simmo carute simmo partute avimmo/ammo vinciuto
Vuje avite/�te parlato site carute site partute avite/ate vinciuto
Loro hanno parlato so� carute so� partute hanno vinciuto
2.4 Imperfetto
-� -� -� -ere
Io parlavo car�vo part�vo venc�vo
Tu parlave carive partive vencive
Isso parlava car�a parteva venc�va
Nuje parl�vemo car�vemo part�vemo venc�vemo
Vuje parl�veve car�veve part�veve venc�veve
Loro parl�veno car�veno part�veno venc�veno
2.5 Passato Remoto
-� -� -� -ere
Io parlaje carette partette vincette
Tu parlaste cariste partiste vinciste
Isso �ssa parlaje carette partette vincette
Nuje parl��emo car�ttemo part�ttemo vinc�ttemo
Vuje parlaste careste parteste vinciste
Loro parl��eno car�tteno part�tteno vinc�tteno
2.6 Futuro Semplice
-� -� -� -ere
Io parlarr�ggio cadarr�ggio partarr�ggio venciar�ggio
Tu parlarraje cadarraje partarraje venciarraje
Isso �ssa parlarr� cadarr� partarr� venciarr�
Nuje parlarrimmo cadarrimmo partarrimmo venciarrimmo
Vuje parlarrite cadarrite partarrite venciarrite
Loro parlarranno cadarranno partarranno venciarranno
2.6.1 Il Futuro semplice, � quasi scomparso nella parlata moderna. Esso
� comunemente sostituito dal Presente indicativo. Il senso del futuro � dato
spesso da un avverbio di tempo.
2.6.2 Si usa anche una forma in cui il senso del futuro, � espresso con
l�uso della perifrasi: �av� � �a� ( dovere da ), con a seguire l�infinito.
-� -� -� -ere
Io aggi� �a parl� aggi� �a car� aggi� �a part� aggi� �a vencere
Tu h� �a parl� h� �a car� h� �a part� h� �a vencere
Isso �ssa ha da parl� ha da car� ha da part� ha da vencere
Nuje amm� �a parl� amm� �a car� amm� �a part� amm� �a vencere
Vuje at� �a parl� at� �a car� at� �a part� at� �a vencere
Loro hann� �a parl� hann� �a car� hann� �a part� hann� �a vencere