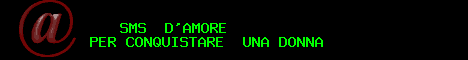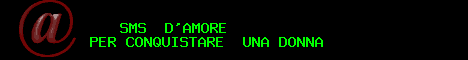
Baudelaire scrive un sonetto di alessandrini, verso usato nella poesia
francese, formato da dodici sillabe.Si nota l'uso dell'enjambement che d� un
ritmo pi� lento, sospeso, per contribuire ad una sensazione di mistero .
Ci troviamo di fronte
forse alla poesia pi� bella del poeta pi� grande di ogni tempo.
Si evidenzia subito la sensazione del contrasto tra i
"pilastri viventi", che danno quel segno di potenza, e le "confuse parole", che
danno il senso di una povert� di vita.
Si tratta di un'immagine onirica, dove si notano cose reali trasfigurate dalla
fantasia.
L�autore percepisce cose che in sostanza non esistono ma vorrebbe conoscere, e questa
conoscenza gli � possibile solo in una forma estraniata.
Cos� pu� recuperare sul piano poetico la dimensione naturalistica, che
l'intellettuale ha perduto.
Una dimensione che non � "naturalistica" solo per il riferimento a profumi,
colori, suoni della natura, ma anche per riferimenti alle "carni di bimbo",
l'innocenza perduta, che non pu� essere ritrovata nella realt� per la presenza
di profumi "corrotti, ricchi e trionfanti".
In parole pi� semplici
L�autore Baudelaire esprime la propria concezione della poesia e del reale. La
realt� concreta , la Natura, nasconde invisibili legami tra le cose; il poeta
� colui che, grazie sua sensibilit� � capace di intuire e riconoscere la foresta
di simboli che si cela dietro il reale e la rivela agli altri uomini.
Da qui discende l'utilizzazione di un linguaggio particolare. musicale,
simbolico, innovativo rispetto alla tradizione poetica precedente, adatto a
illustrare le corrispondenze segrete; un modo di dire capace di esprimere i
percorsi dell'intuizione del poeta . Il linguaggio simbolista riflette una
realt� che � simbolo di altro, si distacca dallo stile poetico tradizionale.
RETORICA
Il
tema del sonetto � costituito dalle corrispondenze, i legami cio� che si
riconoscono nella realt�: ogni oggetto rimanda a qualcos'altro, � simbolo di
qualcos'altro. Spetta all'uomo e in particolare al poeta ritrovare e comunicare
tali simboli.
Questo messaggio si avvale dell'uso di due figure retoriche . Nella prima
quartina, la Natura con i suoi alberi � assimilata mediante l'analogia a un
tempio con le sue colonne: la poesia moderna far� largo uso di questa figura
retorica.
Nelle terzine l'uso della sinestesia rende l'idea che le sensazioni si fondano
in una vasta unit�, in cui ciascuna di esse richiama e corrisponde a un'altra: i
profumi sono definiti infatti freschi, vellutati e verdi, e le sostanze odorose
ambra, muschio, incenso e benzoino tendono a commentare le dolcezze estreme
dello spirito e dei sensi.