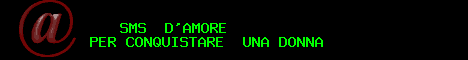���� ������������������������������HOME PAGE�������������������������������������������������������������������������� DIDATTICA SCUOLA
NOZIONI DI METRICA
�Nozioni fondamentali: le sillabe, il ritmo,
la rima
Il verso italiano �
caratterizzato dal numero delle sillabe e dal ritmo.
La sillaba, come nelle altre letterature romanze, costituisce l'unit� metrica: sono cio� da considerarsi uguali i versi che presentano un numero uguale di sillabe. La quantit�, cio� la lunghezza o brevit�, non ha alcuna importanza. Questa � una differenza fondamentale rispetto alla versificazione greca e latina, e si spiega con la storia stessa della lingua italiana.
Nel verso italiano anche
il ritmo ha una certa importanza. Le parole della nostra
lingua hanno un accento proprio che viene mantenuto nel contesto della frase, e
questo fa s� che il ritmo del verso italiano (se confrontato per esempio con
quello francese) sia molto marcato. La sua importanza � comunque inferiore a
quella del numero delle sillabe: i versi con un numero uguale di sillabe sono
da considerare uguali anche se hanno ritmo diverso.
Nei primi secoli la rima
era considerata una componente essenziale, perch� contrassegnava la fine del
verso. Solo nel Rinascimento si tent� per la prima volta la composizione di
versi sciolti, a cui per� i trattatisti del tempo negarono il carattere di
verso.
L'uso poetico ha mostrato
che in italiano i versi sciolti potevano essere sentiti come versi veri e
propri, perch� sono fortemente ritmati, e quindi � facile riconoscerli come
non-prosa. Sebbene la rima non sia una componente indispensabile del verso
italiano, essa continua a mantenere la sua funzione strumentale per il
raggruppamento dei versi.
�Finale del verso e conteggio delle sillabe
Ogni verso italiano pu�
presentare tre uscite diverse:
1. con una parola accentata sulla penultima sillaba
(parola parossitona, o piana)
2. con una parola accentata sulla terzultima sillaba
(parola proparossitona, o sdrucciola)
3. con una parola accentata sull'ultima sillaba
(parola ossitona, o tronca)
Si distingue perci� tra versi piani, sdruccioli e tronchi,
a seconda della parola che si trova alla fine del verso.
Poich� le parole italiane sono per la maggior parte
accentate sulla penultima sillaba (ovvero sono parole piane),
il verso tipico italiano � il verso piano. Questo � importante
per il conteggio delle sillabe. Nella metrica italiana si contano tutte le
sillabe sino alla fine del tipo normale, ovvero fino alla sillaba non accentata
(atona) che segue l'ultima sillaba accentata (tonica) del verso piano.
Al fine del conteggio delle sillabe, i versi
sdruccioli e i versi tronchi si misurano sul verso
piano, contando rispettivamente una sillaba in meno o una sillaba in pi�. Cos�
nel verso sdrucciolo conta solo la prima delle due sillabe atone che seguono
l'ultima sillaba tonica (l'ultima atona non viene contata), mentre nel verso
tronco bisogna aggiungere una sillaba, che in effetti non c'�.
�Sineresi e dieresi
Il conteggio delle sillabe
di un verso pone un problema che � stato discusso a lungo nel corso dei secoli,
al quale i poeti hanno dato risposte spesso in contraddizione con la teoria. La
domanda �: quand'� che le vocali contigue (ovvero in iato) contano per una, per
due (o per pi�) sillabe ai fini delle misura del verso?
Quando due vocali si
incontrano dentro una stessa parola (sono in iato) di norma contano per una
sillaba. Questa figura metrica viene chiamata sineresi.
Un esempio di sineresi
dalla Divina Commedia (poich� l'ultima parola � tronca, si aggiunge
una sillaba dopo l'ultima tonica, e il verso risulta un endecasillabo).
|
Lo |
ciel |
perdei, |
che |
per |
non |
aver |
f� |
(Purgatorio, VII, 8) |
|
1 |
2 |
3 4 |
5 |
6 |
7 |
8 9 |
10 + 1 |
|
Nell'interno del verso
la norma � la sin�resi, all'uscita del verso invece
vale la regola che ciascuna delle due vocali forma una sillaba metrica. Una stessa
parola pu� quindi avere un valore metrico diverso secondo che si trovi
nell'interno o alla fine del verso.
Nel primo esempio le due
vocali (nel pronome "lui") formano una sillaba metrica, mentre nel
secondo esempio le stesse vocali (nel verbo "fui") formano due
sillabe distinte:
|
Ch'eran |
con |
lui, |
quando |
l'amor |
divino |
(Inferno, I, 39) |
|
1 2 |
3 |
4 |
5 6 |
7 8 |
9 10 11 |
|
|
In gi� |
son |
messo |
tanto |
perch'io |
fui |
(Inferno, XXIV, 137) |
|
1 2 |
3 |
4 5 |
6 7 |
8 9 |
10 11 |
|
Non sempre due vocali
contigue nell'interno della parola contano per una sola sillaba. � possibile
per� anche che due vocali consecutive nel corpo di una parola interna al verso
siano considerate metricamente come sillabe distinte e separate. Questa
divisione metrica si dice di�resi.
Nelle maggior parte delle
stampe moderne la dieresi viene indicata mediante due punti collocati sulla
prima vocale: �ere, deliz�oso, mentre nelle stampe antiche (e
in parte delle moderne) il segno della dieresi non compare, e l'interpretazione
metrica viene lasciata a chi legge.
Quando un verso presenta varie
possibilit� di dieresi e persino qualche caso di dialefe non � facile decidere
quali vocali vanno separate e quali fuse insieme. L'impresa si rivela meno
ardua se si conoscono le regole generali (o meglio le consuetudini diffuse),
gli eventuali usi stilistici del poeta, il genere letterario e il gusto del
tempo; nei casi dubbi viene spesso in aiuto il ritmo.
�Sinalefe e dialefe
Quando due vocali
appartenenti a due parole diverse, l'una in qualit� di vocale finale, l'altra in
qualit� di vocale iniziale, si incontrano all'interno del verso, si ha
normalmente una fusione. Ciascuna vocale conserva immutato il suo timbro e
viene pronunciata distintamente, ambedue per�, pur appartenendo a parole
diverse, formano insieme un'unica sillaba metrica. Questo fenomeno, simile a
quello della sineresi, si chiama sinalefe.
Il processo non � diverso
da quello della sineresi all'interno della parola perch� si fonda sullo stesso
fatto fonico, ovvero all'assenza, nella lingua italiana, del fenomeno del
glottal stop, che separerebbe le due vocali.
La sinalefe non contrasta
con la normale pronuncia italiana, e quindi non solo non turba il ritmo del
verso, ma gli conferisce un carattere piacevole e melodioso, a differenza di
quanto avviene in presenza dell'elisione e dell�apocope.
Si prenda ad esempio il
primo verso del Canzoniere di Tetrarca:
|
Voi |
ch'ascoltate_in |
rime |
sparse_il |
suono |
(Canzoniere I, 1) |
|
1 |
2 3 4 5 |
6 7 |
8 9 |
10 11 |
|
Contrariamente all'uso
normale si possono tenere distinte le vocali, e allora le vocali contigue nel contesto
ma appartenenti a parole diverse formano due sillabe metriche diverse. Questo
procedimento, analogo alla divisione che si effettua all'interno di una parola
(dieresi), viene chiamato dialefe in quanto � il contrario
della sinalefe.
Un esempio di dialefe
dalla Divina Commedia(si noti anche la sineresi delle vocali in io e Paolo):
|
Io |
non |
En�a, |
io |
non |
Paolo |
sono |
(Inferno, II, 32) |
|
1 |
2 |
3 4 5 |
6 |
7 |
8 9 |
10 11 |
|
�Elisione, apocope, aferesi
Quando due vocali si
incontrano nell'interno del verso, invece di fonderle insieme (sinalefe) o di conservarle
distinte l'una dall'altra come due sillabe metriche (dialefe), si pu�
eliminarne una lasciando cadere o la vocale finale di parola (elisione)
o la vocale iniziale di parola (aferesi).
Nel verso italiano
l'elisione non serve a eliminare sillabe metricamente eccedenti (questo avviene
con la sinalefe). L'elisione pu� servire a sopprimere un
incontro di vocali, ma questo deve avvenire solo nei casi in
uso nella lingua parlata (es. io t'ho visto). L'elisione non � ammessa
quando, eliminando una desinenza o mutilando una parola monosillaba, si viene a
rendere difficile la comprensione del testo.
L'avverbio ove (=
dove), nell'esempio che segue, diventa Ov':
|
Ov' Amor
me, |
te
sol |
Natura
|
mena |
|
|
1 2 3 4 |
5 6 |
7 8 9 |
10 11 |
|
Nella lingua moderna non
ricorrono pi� alcuni casi diffusi nella lingua antica, e oggi si tende a
limitare ancora di pi� l'uso dell'elisione.
Nell'interno del verso si presentano
altri casi di caduta della vocale finale (apocope) che da un
punto di vista metrico non trovano giustificazione, non servono cio� n� a
eliminare un iato n� a operare elisione, sinalefe o dialefe.
Si tratta di forme abbreviate che vengono usate anche fuori dalla poesia,
e diffuse in parte fino ai giorni nostri, in parte solo nella lingua dei primi
secoli.
Alcuni esempi di apocope
dalla Gerusalemme Liberata del Tasso
|
Degl'inimici il f�r Soldan cammina |
(G.L., IX, 16) f�r = fero (fiero) |
|
Pass�r ne l'Asia l'armi peregrine |
(G. L., IX, 4) pass�r = passaro (passarono) |
Le forme apocopate compaiono
davanti a una parola che inizia per consonante. Quando compaiono anche davanti
a vocale iniziale il troncamento non � dovuto alla vocale della parola che
segue, ma si tratta di forme apocopate per s� stesse. L'accumulazione di forme
apocopate � un distintivo della lingua dei poeti, ed � un uso che si afferm�
solo col tempo. I rimatori della scuola siciliana ne fanno un uso molto ridotto
e limitato a pochi termini, mentre i poeti toscani rendono queste forme via via
pi� frequenti, finch� col Tetrarca e dopo di lui esse diventano un contrassegno
della lingua poetica.
Dal toscano antico sono
passati nella lingua poetica alcuni casi di aferesi, ovvero di
caduta della vocale iniziale in seguito a enclisi (quando la parola si appoggia
alla parola precedente).
I casi pi� frequenti sono:
1. l'articolo il;
2. il pronome il (quando � complemento oggetto,
corrispondente al moderno lo);
3. la preposizione in (anche quando compare come prefisso);
|
caso 1-3 |
Dille, e 'l basciar sie 'n vece di parole |
(Petrarca, Canzoniere, CCVIII,
13) |
|
caso 2 |
S'i' 'l dissi mai, ch'i
vegna in odio a quella |
(Petrarca, Canzoniere, CCVI, 1) |
|
caso 3 |
Ch'addorna e 'nfiora la tua riva manca |
(Petrarca, Canzoniere, CCVIII,
10) |
�Enjambement
La fine del verso coincide
generalmente con la fine della frase o con un parte di essa che ha senso
compiuto. � possibile per� che una parte della frase, strettamente connessa con
ci� che precede, continui nel verso seguente senza pausa. Si parla allora di enjambement.
Nella poesia italiana non
� raro che la frase abbracci il verso seguente, estendendosi in genere
a un emistichio (met� verso, negli endecasillabi e nei versi lunghi) o
a pi� di un verso. L'enjambement, nella poesia italiana, � un fenomeno notevole
solo quando la fine del verso cade all'interno di un gruppo di parole
strettamente collegate, ovvero quando il sostantivo viene separato
dall'aggettivo o il complemento dal predicato, oppure quando il discorso
termina in pieno endecasillabo.
Il sonetto introduttivo
del Canzoniere di Petrarca mostra la coincidenza fra verso ed elementi
della frase.
Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono
Di quei sospiri ond'io nudriva 'l core
In su'l mio primo giovenile errore,
Quand'era in parte altr'uom da quel ch'i' sono,
Del vario stile in ch'io piango e ragiono
Fra le vane speranze e 'l van dolore,
Ove sia chi per prova intenda amore,
Spero trovar piet�, non che perdono.
Quello che segue � invece un esempio di uno stile poetico
caratterizzato dall'uso frequente di enjambement:
Sovente ancor ne la trascorsa sera
La perduta tra 'l gioco aurea moneta
Non men che al Cavalier, suole a la Dama
Lunga vigilia cagionar; talora
Nobile invidia de la bella amica
Vagheggiata da molti, e talor breve
gelosia n'� cagione. A questo aggiugni
Gl'importuni mariti, i quali in mente
Ravvolgendosi ancor le viete usanze...
|
|
�Accento e ritmo
Il verso italiano non �
determinato soltanto dal numero della sillabe, bens� anche dalla sua struttura
ritmica. Elemento essenziale del verso italiano � l'accento
grammaticale, cio� la posizione dell'accento nella parola. La sillaba
che porta l'accento principale della parola nel verso rappresenta l'arsi.
Uno stesso tipo di verso,
con uguale numero di sillabe, pu� presentare strutture ritmiche molto
differenti l'una dall'altra. Nel caso poi dell'endecasillabo, il verso italiano
pi� frequente, la ricca veriet� di strutturazione metrica fa parte della sua
natura (e dei suoi pregi).
Ogni verso italiano ha un accento
costante, e precisamente alla fine del verso, che, come le parole, pu�
essere piano, sdrucciolo (pi� raramente
bisdrucciolo) o tronco. A questo accento segue:
1. una sillaba atona nel verso piano;
2. due sillabe atone nel verso sdrucciolo (tre nel
verso bisdrucciolo);
3. nessuna sillaba nel verso tronco
Il ritmo del verso � determinato dalla posizione degli
altri accenti ritmici all'interno del verso, che possono essere fissi o mobili.
|
Ostel di Cristo, |
i v�ncit�r |
conduce |
|
|
1 2 3 4 5 |
6 7 8 |
9 10 11 |
|
|
E in van l'Inferno |
v� s'opp�se, |
e in vano |
|
|
1
2 3 4 5 |
6 7 8 |
9 10 11 |
|
|
Onde questa |
gentil donna |
si parte |
|
|
1 2 3 4 |
5 6 7 8 |
9 10 11 |
|
Dalla mobilit� delle arsi e dal variare del loro valore
(cio� dalla loro intensit�) deriva che uno stesso verso pu� dar luogo a una
diversa interpretazione ritmica. I versi italiani si devono leggere rispettando
la consueta accentazione delle parole. In caso contrario, cio� se si legge
scandendo meccanicamente le arsi per mettere in risalto il ritmo senza tenere
conto del valore sintattico delle parole nel contesto, si distrugge la natura
del verso.
� quindi sbagliato leggere il verso seguente pronunciando
le arsi allo stesso modo:
|
�nde qu�sta |
g�ntil d�nna |
si p�rte |
|
|
1 2 3 4 |
5 6 7 8 |
9 10 11 |
|
Solo nel corso dei secoli il ritmo venne ad essere
elemento intrinseco del verso italiano: la lirica italiana antica lo ignora del
tutto, la poesia popolare � confusa e imprecisa (o eccessivamente schematica),
nella scuola siciliana si incontrano versi aritmici di ogni tipo. Uno
sfruttamento consapevole dell'elemento ritmico del verso comincia con la lirica
barocca, per poi trovare il suo momento d'oro a partire dalla seconda met�
dell'Ottocento fino al Pascoli.
�Tipologie di verso
I versi italiani si
distinguono in imparisillabi e parisillabi, a seconda che siano composti da un
numero dispari o pari di sillabe.
Versi
imparisillabi
I versi
imparisillabi pi� diffusi nella poesia italiana sono l'endecasillabo, il
settenario e il novenario (rispettivamente di 11, 7 e 9 sillabe).
L'endecasillabo,
oltre all'accento costante sulla decima sillaba, ha un accento principale
mobile, ha un accento principale mobile, che cade per lo pi� sulla quarta o
sulla sesta sillaba. Alla parola che porta questo secondo accento principale
segue (nella lettura) una pausa: il verso ha cio� una cesura.
|
Nel mezzo |
del cammin || |
di nostra |
vita |
(Inferno, I, 1) |
|
1 2 3 |
4 5 6 |
7 8 9
|
10 11 |
|
La cesura divide il verso
in due emistichi, uno pi� breve e uno pi� lungo.
|
S� che |
il pi� fermo || |
sempre era |
'l pi� basso |
(Inferno, I, 30) |
|
1 2 |
3 4 5 |
7 8 9
|
10 11 |
|
|
L'amor |
che move |
'l sole || e l'altre |
stelle |
(Paradiso, XXXIII, 145) |
|
1 2 |
3 4 5 |
6 7 8
9 |
10 11 |
|
La cesura si trova alla
fine della parola che porta l'accento principale, conformemente all'uso comune
del discorso normale in cui la parola viene pronunciata tutta intera senza
spezzarla. La cesura quindi non pu� cadere all'interno della parola, bens�, come
una pausa del discorso, dopo la sillaba atona che segue alla sillaba accentata
(o dopo la sillaba accentata in caso di parola tronca).
|
Il gr�n |
sep�lcro |
ad�ra || e
sci�glie |
il v�to |
|
|
Qu�nto |
pi� des��se |
|| l'�li sp�ndo |
|
|
Le d�nne |
i c�vali�r || |
l'�rmi |
gli am�ri |
|
Per le sue arsi mobili e
di valore diverso, il settenario � un verso ritmicamente affine
all'endecasillabo. La variet� di ritmi, perfettamente rispondente
all'endecasillabo, fa s� che il settenario si associ in modo armonioso agli
endecasillabi nella stanza di canzone.
Il novenario
non si pu� collocare accanto agli altri versi imparisillabi perch�, in tutte le
sue variet�, presenta una struttura diversa da quella degli altri
imparisillabi, ovvero ha gli accenti sempre fissi.
Un esempio di novenario da
La mia sera di Giovanni Pascoli, con gli accenti che cadono sempre sulla
seconda, quinta e ottava sillaba.
|
Il gi�rno fu pi�no di l�mpi; |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
ma �ra verr�nno le st�lle, |
|
1 2
3 4 5
6 7 8 9 |
|
le t�cite st�lle. Nei c�mpi |
|
1 2 3
4 5 6 7 8 9 |
|
c�� un br�ve gre gr� di ran�lle |
|
1 2 3
4 5 6 7
8 9 |
Versi parisillabi
La caratteristica
generale dei versi parisillabi � quella di avere molta meno mobilit�, rispetto
all'endecasillabo e al settenario. Esistono cio� diverse variet� ritmiche per
ogni verso parisillabo, ma ognuna di esse presenta un solo schema di
accentazione (ovvero ha le arsi fisse).
Le caratteristiche
principali dei versi parisillabi possono essere messe in evidenza dall'esame
dei due pi� diffusi versi parisillabi: l'ottonario e il decasillabo.
L'ottonario
compare nella poesia italiana in due forme: quella trocaica e quella dattilica.
L'ottonario trocaico � la forma normale; lo si incontra sporadicamente nella
lirica antica, e nel Quattrocento � il metro pi� usato nella canzone a ballo.
Il decasillabo
si presenta sotto diverse strutture, tra cui le pi� famose sono il decasillabo
senza cesura e quello con cesura fissa:
1) decasillabo senza cesura, con
ritmo costante (arsi fisse la 3�, la 6� e la 9� sillaba), detto anche decasillabo
manzoniano perch� messo in voga da Alessandro Manzoni
Si prenda per esempio il
coro della Scena VI dell'Atto II del Conte di Carmagnola di Manzoni:
|
S'ode |
a d�stra |
uno squ�llo |
di tr�mba |
|
|
a |
sin�stra |
risp�nde |
uno squ�llo |
|
|
d'ambo |
i l�ti |
calp�sto |
rimb�mba |
|
2) decasillabo con cesura fissa.
Questo tipo � detto anche quinario accoppiato, in quanto formato da due
emistichi autonomi sia per ritmo che per computo delle sillabe (non � infatti
ammesso lo iato (dialefe) o la sinalefe tra l'uno e l'altro: questo � il motivo
per cui il secondo emistichio inizia sempre per consonante).
Questo verso divenne molto
popolare nel XIX secolo dal Romanticismo in poi, e Pascoli lo us� spesso.
Si prenda ad esempio la
prima strofa de L'ora di Barga:
|
Al mio cantuccio |
|| |
donde non sento |
arsi fisse: 2� e 4� sillaba || 1�
e 4� sillaba |
|
se non le reste |
|| |
brusir del grano |
arsi fisse: 2� e 4� sillaba || 2�
e 4� sillaba |
|
[...] |
|
|
|
|
suono che uguale, |
|| |
che blando cade |
arsi fisse: 1� e 4� sillaba || 2�
e 4� sillaba |
|
come una voce |
|| |
che persuade |
arsi fisse: 1� e 4� sillaba || 2�
e 4� sillaba |
�Rima, assonanza, allitterazione, verso
sciolto, disposizione delle rime
La rima consiste nella
perfetta identit� di suono dell'uscita del verso a partire dall'ultima vocale
tonica (es. pianto - tanto). Se il suono non � perfettamente
uguale, si ha assonanza. Nella lirica d'arte italiana l'assonanza non
compare (a parte alcune eccezioni), e anche nella poesia italiana antica si
trova raramente.
L'allitterazione si
incontra nella lirica italiana come ornamento retorico del verso. Il primo a
farne largo (e raffinato) uso � Petrarca:
|
Di me |
medesmo |
meco mi vergogno |
Canzoniere I, 11-12 |
|
e del |
mio vaneggiar |
vergogna � 'l frutto |
|
L'allitterazione talvolta
pu� essere utilizzata per generare immagini onomatopeiche.
Esempio: E fra le fronde fremer
dolce l'aura, dove la ripetizione del nesso fr- richiama lo stormire
delle foglie al vento.
Si dicono versi
sciolti(nel senso di liberi) quei versi che non sono legati reciprocamente
dalla rima. Nella poesia anteriore al Rinascimento questo tipo di verso si
incontra solo sporadicamente, e mai nella lirica, perch� la rima faceva parte
del concetto stesso di verso. Nel Cinquecento cominci� a fiorire il verso
sciolto (e in particolare l'endecasillabo) come imitazione della poesia
classica (e in particolare dell'esametro), che non conosceva la rima come elemento
conclusivo del verso. Il verso sciolto verr� soprattutto usato nei generi
letterari che assumon a modello i componimenti dell'antichit� classica.
La rima serve a coordinare
un certo numero di versi. Ci� pu� farsi sia sotto forma di strofa, sia sotto forma
di raggruppamenti diversi.
Per indicare le rime si
adoperano le lettere dell'alfabeto. Quando i versi rimati sono di tipo diverso
occore simboleggiare non solo la rima, ma anche il tipo del verso mediante un carattere
diverso. Generalmente l'endecasillabo si indica con le lettere maiuscole e il
settenario con le minuscole.
Esempio: AbAc AbAc
(ovvero quattro coppie formate da un endecasillabo e da un settenario).
Nella versificazione
italiana si distinguono i seguenti tipi principali di rime:
1. rima baciata (o accoppiata): aa bb cc
2. rima incrociata (o abbracciata): ab ba
o anche cdc cdc
3. rima alterna (o alternata): ab ab ab ab