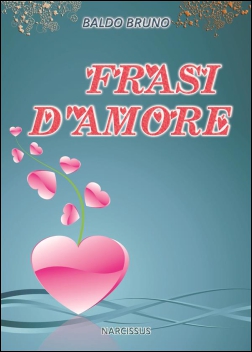TORQUATO TASSO
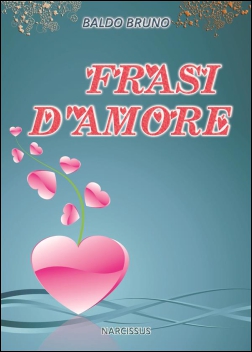

HOME PAGE DIDATTICA SCUOLA POESIE RAGAZZI COMMENTI POESIE FAMOSE LETTERATURA
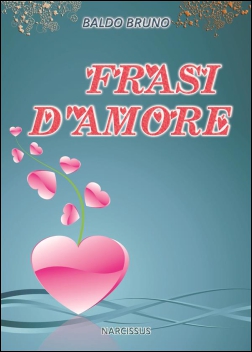

HOME PAGE DIDATTICA SCUOLA POESIE RAGAZZI COMMENTI POESIE FAMOSE LETTERATURA
TORQUATO TASSO
Le peculiarit� della poetica tassiana
Fra classicismo e barocco
La figura di Tasso si colloca nel momento di passaggio dal rinascimento al barocco e nella sua opera si possono individuare elementi che la riconducono all'uno o all'altro di questi due differenti movimenti culturali. Per l'opera di Tasso si usa spesso la definizione di manierismo, indicando con questo termine mutuato dalla storia dell'arte le caratteristiche spesso ambivalenti delle sue creazioni letterarie, sempre in bilico tra il classicismo umanistico-rinascimentale e la tentazione della trasgressione che sar� tipica della sensibilit� barocca.
Tasso � un autore eclettico, che si � cimentato nei diversi generi letterari, anche se la sua fama � legata soprattutto al poema epico, a cui del resto egli stesso ha dedicato la maggior parte delle proprie energie creative. L'analisi delle altre sue opere consente per� di riconoscere alcuni caratteri peculiari della sua poetica, e questo vale soprattutto per le Rime, che costituiscono un vero e proprio laboratorio, un repertorio di motivi e di immagini che si ritroveranno nel poema maggiore. Rispetto al petrarchismo imperante nel Cinquecento, Tasso dimostra una notevole autonomia e indipendenza di giudizio: pi� che alla rigida normativa bembesca ,egli si rif� al modello particolare e originale costituito dal canzoniere di Giovanni della Casa, un poeta che aveva saputo conferire ai propri componimenti un registro elevato e un tono malinconico. Tasso accentua nelle proprie liriche l'elemento musicale, spesso prediligendo la forma metrica del madrigale, meno vincolante rispetto a quella del sonetto, e si serve delle figure retoriche, soprattutto della metafora, che diventer� la cifra stilistica pi� tipica del barocco, con una notevole maestria e una grande capacit� inventiva.
L'autobiografismo dell'opera
La sua produzione lirica � poi caratterizzata dall'autobiografismo e anche questo aspetto � una novit�: l'io poetante di tanta tradizione lirica cinquecentesca non rivelava una sostanza biografica e l'intimismo si risolveva spesso in un atteggiamento di maniera. Nelle liriche tassiane, invece, spesso si avverte la presenza autentica del dramma esistenziale dell'autore, delle sue sofferenze e delle sue contraddizioni.
Gran parte dei tormenti di Tasso nascono, come si � detto nel profilo biografico, dal mai risolto rapporto con gli Estensi e, pi� in generale, con il vuoto rituale formalistico della vita di corte. Il frutto per certi versi pi� interessante di tale rapporto ambivalente, dell'odio-amore che lo lega alla corte ferrarese, si pu� trovare in Aminta, il dramma pastorale composto proprio in occasione di una festa di corte e in cui sotto le sembianze dei personaggi si celano le identit� reali di vari cortigiani. In questo testo destinato allo svago dei nobili e alla celebrazione degli ideali cortesi, infatti, emerge una sottile polemica dell'autore nei confronti dell'insincerit� di rapporti che caratterizza quel mondo a cui egli stesso appartiene e di cui vorrebbe condividere le abitudini e l'ideologia, ma senza riuscirci pienamente. Il poeta vive dunque con un'acuta coscienza lo scarto che avverte tra s� e il modello comportamentale cortigiano, che pure egli ha assunto come proprio. Questa mancata integrazione, acuita da un mai risolto rapporto competitivo con la figura del padre Bernardo che incarnava invece la figura del perfetto cortigiano, pu� spiegare gran parte della malinconia e dell'inquietudine che si possono rilevare in tanti passi delle sue opere.
La riflessione teorica di Tasso
La necessit� di essere adeguato ai modelli prescelti si fa sentire anche nel campo della scrittura e pu� spiegare il fatto che in Tasso la creazione poetica � costantemente accompagnata e strettamente intrecciata alla riflessione teorica. Fin dai giovanili Discorsi dell'arte poetica (pubblicati solo nel 1587), pi� tardi ampliati e in parte rifatti con il titolo di Discorsi del poema eroico (1594), il poeta orienta la sua riflessione sull'esigenza di riprodurre in forme moderne il genere epico classico e sulla messa a punto di uno stile adatto al trattamento di temi eroici. Il nuovo poema epico doveva riuscire a conciliare i canoni aristotelici con quelli religiosi e controriformistici, e nello stesso tempo rispondere alle esigenze di dilettare il pubblico con la variet� dell'invenzione. La fedelt� alle regole aristoteliche, in particolare a quella dell'unit� di azione, consente a Tasso di realizzare nella Gerusalemme liberata una struttura narrativa di grande compattezza; nello stesso tempo, per�, egli si propone di introdurre nel poema una variet� di episodi, rompendo ogni possibile monotonia narrativa e realizzando l'ideale dell' "unit� nella variet�".
Una ricerca sempre insoddisfatta
Dotato di grande spirito autocritico, Tasso cerca di identificare integralmente la propria esistenza con la propria opera e aspira a sentirsi parte di un ordine superiore di regole e convenzioni le cui espressioni perfette sono l'aristotelismo in letteratura, il costume cortigiano in societ� e la chiesa controriformista in ambito religioso: non a caso la sua crisi letteraria e personale, riflessa nel timore ossessivo di non aver scritto un poema ortodosso, coincide con la rottura con gli Estensi.
La vita e l'opera di Tasso sono attraversate da una continua oscillazione tra ubbidienza e trasgressione, tra ricerca di certezze e di regole e fuga e allontanamento da esse, tra fascino dei valori rinascimentali e terreni e adeguamento ossessivo a quelli religiosi e controriformistici. Le sue drammatiche vicende biografiche hanno originato, nei secoli successivi, un vero e proprio "mito": la sua figura � stata vista, soprattutto in et� romantica, come l'emblema del complesso rapporto che lega il genio artistico alle istituzioni politiche e culturali.
La Gerusalemme liberata
Contrariamente ai poemi cavallereschi del Rinascimento, costruiti su racconti in gran parte leggendari e favolosi, il poema del Tasso ha uno sfondo storico, che � quello della prima crociata per la conquista del Santo Sepolcro di Cristo, avvenuta nel 1099. E storici sono pure in gran parte i per�sonaggi dell�opera, anche se il Tasso ne in�terpret� spesso arbitrariamente la persona�lit�, cos� come si mosse tra gli episodi reali di quella celebre impresa con molta libert�, non disdegnando di fare intervenire nelle vi�cende angeli e maghi, come gli antichi poeti epici facevano intervenire gli d�i dell�Olimpo .Nella Gerusalemme sono cos� abban�donati i temi frivoli, giocosi, ironici, di pura evasione fantastica, che avevano caratteriz�zato opere come �Orlando innamorato del Boiardo o l�Orlando furioso dell�Ariosto. Il poema � opera, diremmo oggi, �impegna�ta�, cio� tesa all�esaltazione di una grande impresa eroica e religiosa, cantata dal poeta per richiamare l�umanit� dei credenti agli al�ti ideali di fede che l�avevano ispirata e resa possibile. In questo modo il poeta si ade�guava agli ammonimenti che erano venuti alla cattolicit� � dopo lo scisma luterano �dal concilio dijrento, conclusosi proprio in quegli anni (1563) con una rigorosa riaffer�mazione dei valori cristiani tradizionali della Chiesa di Roma. Questo per� non signif�ca che il poema sia fredda celebrazione; la pro�fonda sensibilit� umana del poeta, la sua in�clinazione quasi morbosa alla passione d�a�more, la sea straordinaria capacit� di pene�trare nelle pi� nascoste pieghe dell�anima, arricchiscono il poema di numerosi episodi e personaggi, dominati e tormentati ora dal�le pi� pure ansie spirituali, ora dalle pi� sconvolgenti pene d�amore, ora dalle pi� vi�branti ambizioni eroiche e religiose; col ri�sultato che poche opere sono come questa ricche della multiforme, imprevedibile capa�cit� del cuore umano di sentire e di patire.
I personaggi
I personaggi pi� importanti sono Goffredo di Buglione, principe della Lorena, che effetti�vamente fu l�anima della conquista; Tancre�di, principe normanno, altra figura storica; Rinaldo, personaggio d�invenzione, che il poeta immagina progenitore della famiglia d�Este, alla quale il poema � dedicato; e poi Clorinda e Armida, Sofronia e Erminia, le donne ardenti e languide di alcuni dei pi� celebri episodi; e, tra i musulmani, Aladino e Solimano e tanti altri, curati, dall�appassio�nata attenzione del poeta, non meno dei personaggi principali. Lo sfondo sono le mu�ra di Gerusalemme, le foreste che attornia�no la citt�, le tende dei cristiani, le case del�la citt� assediata, incantati giardini e quel Sepolcro di Cristo cui tendono con tutte le loro forze i crociati e davanti al quale, sul fi�nire del poema, Goffredo di Buglione scio�glier� il proprio voto.
I canti
I canti del poema, che sono venti e in otta�ve, com�era consuetudine per i poemi caval�lereschi, si snodano intorno alle seguenti vi�cende:Canto I. Dall�alto dei cieli, Dio volge losguardo sul campo dei cristiani e decide che il comando delle operazioni per la conquista della citt� venga affidato a Goffredo di Bu�glione, che � il pi� degno e il pi� ricco di fe�de. Vengono passati in rassegna i principi cristiani, tra i quali spiccano Rinaldo e Tan�credi, che � tormentato da un infelice amore per una musulmana, Clorinda. Goffredo, di�venuto capo dell�esercito, si prepara ad as�salire la citt�, difesa dal soldano Aladino.
Canto Il. In Gerusalemme scompare un�im�magine sacra della Madonna dalla chiesa dei cristiani; Aladino ne incolpa i cristiani medesimi e decide di perseguitarli. Una fan�ciulla cristiana, Sofronia, si accusa del furto; altrettanto fa un giovane, Olindo, che � in�namorato di lei e vuole salvarla. I due giova�ni vengono condannati a perire insieme sul rogo. Clorinda, la guerriera, si commuove della loro vicenda e per i suoi meriti ottiene dal re la loro liberazione. Anche l�Egitto, per voce del guerriero Argante, dichiara guerra ai cristiani,
Canto III. I cristiani sono in vista di Gerusa�lemme e salutano commossi la citt� dov�� sepolto Cristo. Clorinda esce loro incontro e combatte con Tancredi che, avendola rico�nosciuta, si limita a difendersi e e dichiara il suo amore. In una imboscata guidata da Ar�gante, muore il principe cristiano Dudone, cui vengono celebrati solenni funerali.
Canto IV. Su istigazione del dio dell�inferno, il mago ldraote manda la sua bella nipote Armida al campo cristiano per chiedere a Goffredo l�aiuto di dieci guerrieri che vendi-chino un torto da lei sofferto nella sua pa�tria, Damasco. Scopo dell�inganno � quello di trascinare in avventure lontane i migliori guerrieri cristiani. L�inganno riesce.
Canto V. La scelta dei guerrieri genera di�scordie nel campo, dal quale si allontanano Rinaldo e parecchi altri, sedotti dalla bellez�za di Armida. Intanto � annunciato l�arrivo della flotta egiziana.
Canto VI. Argante sfida a singolar tenzone un cristiano. Accetta Tancredi, ma il duello viene interrotto per il calare della notte. Er�minia, figlia del re di Antiochia, innamorata di Tancredi, veste le armi di Clorinda e cerca di raggiungere la tenda dei principe nor�manno. Scoperta, � costretta a fuggire.
Canto VII. Erminia in fuga si rifugia presso alcuni pastori, che vivono una loro semplice vita in mezzo alla selva, lontani dalle passio�ni del mondo e dalla guerra. Tancredi, che ha inseguito Erminia credendola Clorinda, finisce momentaneamente nel castello in�cantato di Armida ed � sottratto cos� ai suoi doveri; il suo duello con Argante � continua�to da Raimondo di Tolosa, e disturbato dal�l�intervento dei diavoli.
Canto VIII. Impresa di Solimano, che fa strage dei cristiani danesi. Giunge la notizia che Rinaldo � morto. Durante la notte, la fu�ria Aletto porta discordia nel campo dei cri�stiani, facendo credere che responsabile della morte di Rinaldo sia Goffredo. La di�scordia � sedata a stento.
Canto IX. Continuano le imprese di Solima�no; morte del suo paggio Lesbino. Interven�gono nella battaglia anche Clorinda e Ar�gante e numerosi guerrieri cristiani.
Canto X. Solimano � condotto in Gerusa�lemme dalle arti magiche di lsmeno. Al campo cristiano si apprende che Rinaldo non � morto, ma anzi ha liberato i cavalieri sedotti dalle grazie di Armida e ora si sta di�rigendo ad Antiochia.
Canto XI. Dopo una solenne processione al monte Oliv�to, i cristiani attaccano la citt� avvicinando alle mura una grande torre. Si accendono furiosi combattimenti, Goffredo � ferito, ma grazie a Tancredi i cristiani han�no la meglio finch� cala la notte.
Canto XII. Nella notte, Clorinda e Argante escono dalla citt� e incendiano la torre, Tan�credi assale Clorinda, mentre Argante riesce a porsi in salvo in citt�. Nel duello che se�gue. Clorinda � colpita a morte e chiede al suo avversario il battesimo. Toltole l�elmo, Tancredi la riconosce e s�accorge cos� di avere ucciso la donna che ama. La sua di�sperazione lo porta sull�orto del suicidio.
Canto XIII. Per le arti magiche di Ismeno, la selva dalla quale i cristiani si forniscono di. legname per lp torri d�assalto, diviene un luogo d�incanti dove nessuno pu� entrare. Contemporaneamente Ismeno provoca una terribile siccit� che tormenta gli assedianti. Solo le ardenti preghiere di Goffredo otten�gono da Dio un temporale.
Canto XIV. Goffredo manda due messi a cercare Rinaldo; si apprende che il giovane guerriero, vittima degli incantesimi di Armi-da, � chiuso in un suo castello fatato, nelle lontane Isole Fortunate.
Canto XV. I due messi viaggiano verso le Isole Fortunate e riescono a entrare nel ma�gico castello.
Canto XVI. Rinaldo, raggiunto dai due me si e liberato dall�incantesimo, abbandona Armida che � innamorata di lui e ritorna sul�la via del campo.
Canto XVII. Armida si reca in Egitto a cer�care un guerriero pagano che la vendic dell�abbandono di Rinaldo; il quale, intant giunto in Palestina, ottiene nuove armi, tra cui uno scudo, che celebra le glorie delta ca�sa d�Este.
Canto XVIII. Rinaldo, purificatosi dalle s colpe sul monte Oliveto, rompe gli incan della selva e cos� i cristiani possono cost
re tre torri, con l�ausilio delle quali, do aspra battaglia, riescono a entrare in citt�. mago Ismeno, dopo averti invano contrast ti con le sue arti, muore. E intanto annunc� to l�arrivo dell�esercito egiziano.
Canto XIX. Argante combatte in duello conTancredi e resta ucciso. Tancredi, ferito gra-. vemente, � soccorso da Erminia. Saccheg�gio di Gerusalemme. Aladino si rifugia nella torre di David.Canto XX. All�arrivo dell�esercito egiziano la battaglia si fa terribile. Tra i morti � il grande Solimano e molti dei campioni di Ar�mida, che si rappacifica con Rinaldo e pro�mette di farsi cristiana. Cadono pure, tra i tanti, due eroici sposi cristiani, Gildipppe e Odoardo; Aladino � ucciso da Raimondo diTolosa; cade infine l�ultimo campione musulmano Emireno per mano di Goffredo, pu� cos� entrare vittorioso nel Santo Sepolcro e sciogliere il voto.
L�Aminta
� una commedia pastorale, o favola bo�schereccia, come la chiam� il poeta, e prende nome dal protagonista, il pasto�re Aminta. Egli ama, fin dall�infanzia, una ninfa, Silvia, che lo respinge anche quando egli la salva dalle furie di un sa�tiro. Un giorno Silvia si libera a stento da un branco di lupi; Aminta crede che essa sia morta e cerca egli pure di mori�re gettandosi da una rupe. Silvia allora si commuove, corre da lui, lo trova vivo ai piedi della rupe, salvato da un provvi�denziale cespuglio che aveva arrestato la caduta, e gli rivela il suo pentimento e il suo affetto.La trama, come si vede, � un puro pre�testo per intessere un gioco raffinato di sospiri d�amore, di offerte, di repulse, dieleganti schermaglie; e i persona9gi non sono che la proiezione, in un mon�do di evasione e di sogno, (secondo il costume dell�epoca) delle dame e dei cavalieri della corte estense per i quali la commedia fu scritta.L�opera, rappresentata la prima volta nel 1573 nell�isola di Belvedere, sul Po, dove gli Este possedevano una loro villa di delizie, fu accolta immediatamente come un capolavoro ed ebbe uno straordinario influsso su tutta la produ�zione teatrale e lirica dei due secoli suc�cessivi, specialmente sul melodramma. La sua grazia sospirosa � tale che ancor oggi essa viene rappresentata e studia�ta come esempio unico del nostro tea�tro rinascimentale.