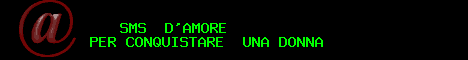
|
|
Nunzio |
|
|
Donna del paradiso,
|
|
|
5 |
|
che la gente l'allide ! |
|
Madonna |
|
|
Como esser porr�a |
|
|
10 |
|
Cristo, la speme mia, |
|
Nunzio |
|
|
Madonna, egli �
traduto, |
|
|
15 |
|
fatto n'ha gran mercato. |
|
Madonna |
|
|
Succurri, Magdalena, |
|
Nunzio |
20 |
|
Succurri, Donna, aiuta ! |
|
Madonna |
|
|
O Pilato, non fare |
|
|
25 |
|
lo figlio mio tormentare, |
|
Popolo |
|
|
Crucifige, crucifige !
|
|
|
30 |
|
secondo nostra lege, |
|
Madonna |
|
|
Priego che
m'entend�ti, |
|
|
35 |
|
de quel ch'avete pensato. |
|
Nunzio |
|
|
Tragon fuor li ladroni |
|
Popolo |
|
|
De spine se coroni ! |
|
Madonna |
40 |
|
O figlio, figlio,
figlio ! |
|
|
45 |
|
figlio, co' non respondi ? |
|
Nunzio |
|
|
Madonna, ecco la
cruce, |
|
|
50 |
|
ove la vera luce |
|
Madonna |
|
|
O croce, que farai ? |
|
|
55 |
|
ch� non ha en s� peccato ? |
|
Nunzio |
|
|
Succurri, piena de doglia, |
|
Madonna |
60 |
|
Se glie tollete 'l vestire, |
|
Nunzio |
|
|
Donna, la man gli � presa |
|
|
65 |
|
e nella croce � stesa, |
|
|
70 |
|
e lo dolor s'accende, |
|
|
75 |
|
tutto l'han desnodato. |
|
Madonna |
|
|
Ed io comencio el corrotto. |
|
|
80 |
|
Meglio aver�en fatto |
|
Cristo |
|
|
Mamma, o' sei venuta ? |
|
|
85 |
|
mortal me d�i feruta, |
|
Madonna |
|
|
Figlio, che m'agio
anvito, |
|
|
90 |
|
figlio, chi t'ha ferito ? |
|
Cristo |
|
|
Mamma, perch� te lagni
? |
|
|
95 |
|
ch'al mondo agio acquistato. |
|
Madonna |
|
|
Figlio, questo non dire, |
|
|
100 |
|
Ch'una agiam sepultura, |
|
Cristo |
|
|
Mamma col core affetto, |
|
|
105 |
|
entro a le man te metto |
|
Cristo |
|
|
Joanne, esta mia mate |
|
|
110 |
|
aggine pietate |
|
Madonna |
|
|
Figlio, l'alma t'�
uscita, |
|
|
115 |
|
figlio attossicato ! |
|
|
120 |
|
Figlio bianco e
biondo, |
|
|
125 |
|
figlio de la dolente, |
|
|
130 |
|
sentito aggio 'l
coltello |
|
|
135 |
|
mate e figlio a un cruciato. |
La lauda mette in evidenza gli ultimi, drammatici momenti della vita di Cristo e
si caratterizza per il fatto che l�attenzione, anzich� sulla sofferenza di Ges�,
� focalizzata su quella della Madonna. Attingendo ai Vangeli, ad alcuni testi
latini che avevano gi� messo in primo piano la sofferenza della Vergine1, a
rappresentazioni sacre diffuse nel XII secolo in Italia settentrionale2 e
centrale3, Jacopone mette in scena una sorta di Passione della Vergine.
L�impostazione teatrale di questo testo � con tutta evidenza differente da
quelli fin qui antologizzati � si inserisce nella tradizione della lauda
perugina, che si orientava, piuttosto che verso l�ascetismo o il misticismo,
nella direzione di una divulgazione del Vangelo e di una umanizzazione dei temi
religiosi. La lauda perugina era affidata alla recitazione di alcuni solisti e
di un coro, e costituisce un passo importante verso quello spettacolo che nel
Quattrocento avrebbe preso il nome di �sacra rappresentazione�. Le
caratteristiche tematiche della lauda perugina contribuiscono a spiegare uno dei
dati pi� significativi di questa lauda: il fatto cio� che la passione della
Vergine risulti, in gran parte, una passione profondamente umana; che Maria
appaia, pi� che come �donna de Paradiso�, anzitutto come una madre disperata;
che si mostri spesso ignara delle implicazioni teologiche della sofferenza del
figlio4.
L�incomunicabilit� tra Maria ed i vari interlocutori (vv. 4-83).
Le prime venti strofe che seguono alla ripresa (e cio� i vv. 4-83) hanno
funzione prettamente diegetica. La narrazione � affidata in gran parte al
Nunzio, che esorta Maria a correre ai piedi della croce e interviene
successivamente (vv. 64-75) a descrivere i particolari della crocifissione in
maniera fortemente realistica.
A fronte di questo racconto stanno le invocazioni della Madonna, che �
inutilmente � cerca di chiamare in causa vari interlocutori. Dapprima viene
invocato l�aiuto della Maddalena (vv. 16-19), che per� tace; all�invocazione
rivolta a Pilato (vv. 24-27) risponde implicitamente, in modo ostile, la folla,
il cui Crucifige sancisce la scelta in favore di Barabba. Nessun effetto ottiene
neanche l�invocazione al Popolo (vv. 32-35). Allora Maria invoca ripetutamente
il figlio, con significativi riferimenti alla fisicit� del legame (v. 47, vv.
60-63). Infine, in mancanza di una risposta, Maria chiama come sua
interlocutrice la croce, ribadendo la propria umanissima ma inascoltata protesta
sull�innocenza di Ges� (v. 55). Si � detto prima che la Passione di Cristo
diviene qui Passione della Vergine; ma si potrebbe osservare che, prima ancora
che alla Passione, il personaggio di Maria rimanda al dogma della Incarnazione:
la Madonna � madre e in nome di questo legame invoca su di s� tutte le
sofferenze del figlio (significativo in tal senso il lamento dei vv. 76-83).
La crocifissione viene descritta in tre strofe (vv. 64-75), collocate
esattamente al centro del componimento: la lauda potrebbe pertanto essere
suddivisa in un primo blocco di quindici strofe (che contengono il dialogo, o
meglio il mancato dialogo tra Maria e gli altri personaggi) e in altre quindici
strofe che contengono il lamento funebre (che comincia con i gi� citati vv.
76-83 e riprende da v. 112 alla fine) inframmezzato dall�unico vero dialogo del
componimento: quello tra la madre e il figlio.5
Il dialogo tra la Madre ed il Figlio (vv. 84-111).
A tale dialogo sono dedicate sette strofe. Si tratta, anche stavolta, di un
dialogo segnato da una forte incomunicabilit�. La voce di Cristo che scende
dall�alto della croce appartiene a una dimensione soprannaturale, molto diversa
da quella di Maria. Dapprima egli rimprovera affettuosamente la madre per
essersi recata in quel luogo; poi le ricorda il suo dovere di rimanere a fianco
degli apostoli; infine, di fronte al disperato �voglio teco morire� del v. 97,
la affida all�apostolo Giovanni. Non � certo casuale che Cristo pronunci
esattamente tre battute, come non era casuale il fatto che il racconto della
crocifissione fosse anch�esso contenuto in tre strofe (vv. 64-75): si tratta di
riferimenti impliciti alla Trinit� e quindi alla natura divina di Ges�. Maria
invece rimane umanissima perfino quando chiama in causa il mistero della
Trinit�: la triplice invocazione del v. 89 (�figlio, pat�e mmarito�),
trasferisce infatti lo Spirito Santo in una dimensione quotidiana e familiare
(tanto che il verso pu� tranquillamente interpretarsi come l�affermazione che,
per una madre, il proprio figlio � tutto).
Il piano soprannaturale su cui si muove Cristo e quello umano di Maria si
intersecano tuttavia nell�uso di una parola, il vocativo �mamma�, ripetuto per
tre volte da Cristo; una parola che rimanda etimologicamente, come si � notato
nel commento, a quella stessa fisicit� dell�allattamento gi� richiamata da Maria
al v. 47.